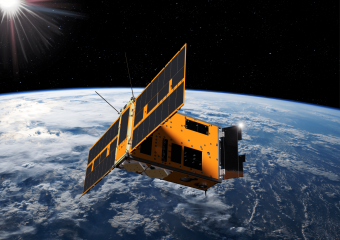Rappresentata come il Paese più isolato e impenetrabile del mondo, la Corea del Nord fa parlare di sé solo raramente. Titoli sensazionalistici e giudizi senza appello. Poi i riflettori si spengono e la Corea del Nord sprofonda di nuovo nel buio.
In questo testo i pregiudizi vengono accantonati e si dà voce all’altra parte. Come si mostra “Il Regno Eremita” al visitatore occidentale? Come il cittadino nordcoreano racconta la storia del suo Paese? Perché a Pyongyang è sparito il centro storico? Come è concepito il sogno della riunificazione? Qual è l’origine del culto dello Stato? Molte domande rimangono aperte. Si aprono possibili campi d’indagine. Tanti spunti di riflessione che gettano una nuova luce anche sulla nostra cultura.
Premessa
Uno dei paesi più impenetrabili del mondo, Il Regno Eremita, Il più grande enigma dell’Asia. Definizioni che evocano un luogo misterioso, inaccessibile, quasi sconosciuto. Eppure è difficile trovare un altro luogo sul quale siano state fatte affermazioni più perentorie e sibilline, più granitiche e definitive. Testi che sembrano non conoscere il dubbio, testi sui quali aleggia l’ombra della propaganda.
La Corea del Nord suscita domande. E proprio qui sta il suo fascino. Viaggiare in Corea del Nord significa attraversare un Paese-Fortezza, un Paese pervaso da un culto che si fonda su un mito, un Paese che ha intrapreso un originale esperimento. Ma se lo faremo con occhi nuovi e con la mente sgombra dai pregiudizi, e se saremo disposti anche ad ascoltare le ragioni degli altri, allora il nostro viaggio potrebbe rivelarsi sorprendente e potrebbe portarci fino a vedere noi stessi riflessi in uno specchio. E le domande che ci porremo, se pur resteranno in gran parte senza risposta, lasciando avvolto nel suo alone di mistero quel mondo che invano cerchiamo di scoprire, non mancheranno di gettare nuova luce sulla nostra cultura e sul nostro rapporto con gli altri.
Varcando la soglia: nel Regno Eremita
Dall’alto, adagiata nella grande piana verde, Pyongyang mi appare diversa da ogni altro luogo al mondo. Risaie e piantagioni di mais si estendono fino a pochi metri dalla pista d’atterraggio, sotto un cielo appena velato dalla tenue foschia, mentre qualche contadino si aggira per la campagna umida e rigogliosa.
Già all’arrivo all’aeroporto ho l’impressione di non essere in uno dei tanti “non luoghi” del mondo, luccicanti di lussuosi negozi, stessi marchi, stessi prodotti, stessi anonimi, asettici luoghi, ove a volte dimentico dove sono: Roma? Mosca? Pechino? No, qui sono a Pyongyang.
L’aeroporto internazionale Sunan ci accoglie in un grande salone grigio, semplice, essenziale, le pareti di un tenue e riposante verdino. Le formalità sono abbastanza veloci, i telefoni vengono rapidamente controllati e restituiti. La delegazione di ospiti stranieri è già attesa e non c’è bisogno di tanti controlli: saremo sempre seguiti da due guide e da un autista, che saranno i nostri angeli custodi per tutta la durata della visita.
Mentre ci dirigiamo verso l’hotel e la guida ci dà le prime informazioni introduttive sul Paese, la mia curiosità è tutta rivolta verso l’esterno, a controllare quanto, a un primo impatto, le descrizioni lette corrispondano al mondo realmente osservato. Già il discreto traffico di macchine, le molte persone per le strade e l’atmosfera serena sembrano smentire il clima cupo e triste dei racconti occidentali.
Mi è capitato spesso di leggere come Pyongyang sia una città surreale, artificiale, una specie di enorme palcoscenico senza attori.
La città appare ultramoderna e del suo volto antico non si vede traccia alcuna. Una scelta ideologica? O non sarà la folle idea dell’uomo nuovo che abbia portato ad eliminare il ricordo del passato? O il parto di un visionario progetto futurista? Sono le prime di una lunga serie di domande che mi porrò nel corso della mia visita in Corea del Nord. Provo a chiedere. No. Non è nulla di ciò che ho pensato. Ѐ la guerra. Soltanto la guerra. Pyongyang fu distrutta dalla guerra, l’ultima, la più disastrosa di una lunga serie di guerre. E non fu la memoria dell’antica città, peraltro mai esistita in Occidente, ma gli effetti di quella guerra tremenda e dimenticata ad essere rimossi dalla memoria breve dell’uomo occidentale.
La mia curiosità si fa più viva. Come i Nordcoreani raccontano la loro storia? Così acquisto un libro che presenta la Corea del Nord agli stranieri e cerco la storia di Pyongyang.
Migliaia di anni fa, uno dei primi Stati d’Oriente, quello del re Tangun, aveva stabilito proprio qui la sua capitale. Le genti di quel regno leggendario affermavano di discendere dal sole. Tanti secoli passarono, venne il periodo chiamato dei Tre Regni e Pyongyang divenne la capitale dello Stato di Koguryo. All’inizio del decimo secolo, Koryo fu il primo Stato unitario della penisola coreana e portò la sua capitale a Kaesong. Pyongyang continuò a mantenere un ruolo importante nella vita politica, economica e culturale del paese. L’età moderna fu segnata da una serie di invasioni, fino all’occupazione giapponese dell’inizio del secolo scorso. Infine venne la guerra statunitense, la più disastrosa. I massicci bombardamenti ridussero la città in cenere. Dell’antico centro e delle sue strette vie, dei suoi templi e padiglioni, delle sue fortezze e delle sue porte non restava più nulla. Tutto era da rifare. Ma il popolo coreano, con grande coraggio e determinazione, si mise al lavoro e riedificò dalle fondamenta la sua capitale. E lo fece secondo un progetto grandioso.
Altissimi edifici in pietra, in vetro e in cemento si levarono al cielo, giganteschi monumenti di marmo ornarono piazze vastissime, larghi viali vennero bordati d’alberi, enormi spazi furono trasformati in parchi e giardini perfettamente curati.
Come fu possibile un lavoro così straordinario? Penso che la risposta stia nella forte coesione sociale e nazionale del popolo coreano, che si fonda sull’esistenza di un antico spirito comunitario. Quell’antico spirito fu mosso da un fulcro moderno, e la figura del Grande Leader divenne il cuore odierno di un sentimento antico.
Ѐ facile trovare, per tutto il Paese, libri che raccolgono aneddoti sui leader coreani. Sono tradotti nelle principali lingue europee: inglese, francese, spagnolo, russo. Sono storie che parlano il linguaggio del mito e che, soprattutto nel caso del Presidente Kim Il Sung, raccontano le gesta eroiche di un personaggio fuori dal comune, coi caratteri tipici dell’eroe dotato di grande generosità, nobili sentimenti, amore per il popolo.
A questo punto, non possiamo non domandarci: come il mito del Grande Leader ha potuto essere trasmesso e conservato intatto attraverso il tempo?
Penso che osservare più da vicino la società e le istituzioni create nel corso di quasi settant’anni di storia socialista possa essere un buon modo per aiutarci a comprendere.
Prima di tutto le istituzioni culturali. Le scuole, dall’asilo all’università, hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento di quello spirito comunitario che ruota attorno alla figura del Padre della Patria. I coreani si considerano un’unica famiglia, tutti figli dello stesso padre, armoniosamente uniti attraverso il comune interesse al mantenimento della patria socialista. L’identificazione con uno Stato che si prende carico di ogni bisogno dei suoi cittadini, per tutto il corso della loro vita, è totale.
Il nostro programma prevede la visita al Palazzo dei bambini. L’altissimo livello tecnico raggiunto dai fanciulli, spesso molto giovani, nell’uso di strumenti musicali, nel canto e nelle arti figurative ci sorprende tutti. Non possiamo non pensare alle nostre “recite di fine anno”. Un confronto impossibile.
Ancor più sorprendente è la visita alla Biblioteca Nazionale di Pyongyang. L’edificio ha più di 600 stanze: sale di lettura, sale per l’ascolto della musica, aule per lo svolgimento di lezioni, laboratori d’informatica, sale conferenze ed un’aula magna in grado di ospitare 800 persone. La ricerca dei testi è effettuata tramite postazioni informatiche collegate alla rete coreana chiamata Kwangmyong, mentre la distribuzione avviene per mezzo di un efficiente sistema di trasmissione automatica. Visitando la Grande Casa degli Studi del Popolo, come è anche chiamata, apprendiamo che qui la biblioteca non è concepita solo come luogo di ricerca e di lettura. Ho potuto osservare di persona due aule in cui si stavano svolgendo una lezione di storia coreana ed un corso di lingua inglese. La cortese giovane che ci faceva da guida ci ha spiegato che ci sono un centinaio di professori a disposizione di chi abbia bisogno di spiegazioni e traduzioni e che i cittadini coreani possono informarsi dei corsi di lingue e delle conferenze che si svolgono nell’edificio attraverso l’emittente televisiva nazionale.
Ma le sorprese non finiscono qui. Contrariamente a quanto saremmo portati a pensare, la storia antecedente al periodo socialista è oggetto di grande attenzione. Visitando Kaesong, ho potuto vedere con quale cura sono stati ricostruiti i quartieri tradizionali. Le case lungo il fiume, addossate l’una all’altra, con i loro tetti dalla forma a pagoda, danno al paesaggio umano un tocco di grazia ed eleganza, secondo quello che era un tempo il senso estetico coreano. I vecchi testi parlano di una particolare attenzione posta nella scelta del sito abitativo. L’ideale era un luogo riparato dalla montagna, abitata dai quattro angeli protettori: il dragone azzurro a est, la tigre bianca a ovest, l’uccello rosso a sud e la tartaruga a nord. Un corso d’acqua doveva scorrere davanti all’abitazione. Oggi le file di case lungo il fiume, costruite nel fertile suolo verdeggiante di Kaesong, conservano abbastanza quel rapporto armonioso con la natura che era proprio delle case di un tempo.
Ma la notizia che più desta la mia meraviglia, riferita con orgoglio dalla guida locale, è che gli abitanti di Koryo, parola da cui ha origine la parola Corea, nella prima metà del XII secolo, due secoli prima di Gutenberg, furono i primi al mondo a inventare i caratteri metallici per la stampa.
Molti sono ancora i luoghi di interesse che potrebbero essere fonte di riflessione e motivo di confronto con la nostra cultura, dai templi buddhisti ai parchi naturali, dalle cooperative agricole alle conquiste tecnologiche. Ma lo spazio è tiranno.
Concludiamo la nostra visita a Phanmunjom, dove una sottile striscia di cemento fra tre baracche azzurre segna il confine fra le due Coree. Siamo nella “zona demilitarizzata”, quella terra di nessuno che attraversa la penisola lungo il trentottesimo parallelo. Oggi non c’è nessuno a sud e il sogno della riunificazione sembra allontanarsi. I soldati nordcoreani raccontano la storia della separazione e il sogno, mai tramontato, della riunificazione. Qual è la posizione della Corea del Nord su questo importante problema?
Il governo della Corea del Nord ritiene che la riunificazione nazionale debba realizzarsi senza l’intervento di forze straniere e senza l’uso delle armi e, a partire dal 1953, in occasione dei colloqui di pace, ha riproposto la sua idea per oltre duecento volte. A questo punto una domanda sorge spontanea: come è possibile, dopo tanti anni, in presenza di sistemi economici così diversi ed ormai consolidati, realizzare un tale sogno? La risposta della Corea del Nord a tale domanda è stata la proposta di una confederazione di due Stati basati sul principio della pacifica convivenza, ognuno rispettoso dell’altrui sistema economico e politico. Il Governo confederale dovrebbe rappresentare un Paese neutrale che non fa parte di nessuna alleanza militare internazionale. Non dimentichiamo, però, che a sud del trentottesimo parallelo vengono svolte regolarmente esercitazioni statunitensi in concomitanza con l’esercito sudcoreano e che gli Stati Uniti sono presenti nel Sud con oltre 40.000 soldati ed un arsenale atomico con più di mille armi nucleari dislocate in tutto il Paese. Ciò significa un’arma nucleare ogni 100 chilometri quadrati, la più alta densità atomica del mondo.
Considerazioni finali
Il viaggiatore che visita la Corea del Nord si trova di fronte a un mondo che, per la sua forte originalità e per la sperimentazione di un modello di società alternativo a quello del resto del mondo, è continua fonte di riflessione su fenomeni che da secoli sono stati oggetto di ricerca da parte di filosofi ed antropologi.
Qual è il rapporto individuo-società? Quanto un sistema politico riesce a condizionare il pensiero umano? Che significa essere liberi? La parola libertà può avere un significato oggettivo? Come nasce un mito? Ѐ possibile realizzare una società giusta?
Il problema della società giusta è stato da sempre al centro della riflessione umana. Cos’è la giustizia in senso astratto nessuno è mai riuscito a definirlo. Tutti siamo però di fronte a concreti ed indubitabili esempi di ingiustizia: una società con persone ricchissime accanto ad altre senza lavoro, persone che vivono in dimore sontuose accanto ad altre che vivono per strada. Senza parlare di drammi sociali immensi, quali la droga, la prostituzione, la criminalità, il razzismo, il gioco d’azzardo. In Corea del Nord questi mali sono quasi inesistenti. La casa, la scuola e la sanità sono gratuite, così come le gite d’istruzione, i campeggi e le attività artistiche e sportive. I generi di prima necessità sono venduti allo stesso prezzo, molto basso, in tutto il Paese. Le tasse non esistono. Il lavoro c’è per tutti. La donna e l’uomo sono uguali e quindi la prostituzione è inesistente. La delinquenza è un fenomeno quasi sconosciuto. L’attenzione all’ambiente è esemplare: le vie sono alberate, i giardini e i parchi curatissimi, coperti di aiuole fiorite e frequentati da uccelli, le industrie pesanti lontane dalle città e stazioni di rilevazione dell’inquinamento controllano l’ambiente in tutto il Paese.
Percorrendo la Corea del Nord verso la frontiera cinese, si ha l’impressione di attraversare due mondi, il simbolo della recente storia umana: a est la verdeggiante campagna coreana, le montagne boscose, i corsi d’acqua cristallina, i villaggi immersi nelle piantagioni di riso e mais; a ovest il paesaggio cinese: una foresta di edifici enormi, centri commerciali che spuntano come funghi, un ponte sospeso sul fiume, rimasto incompleto sul versante coreano. Quel ponte rappresenta il futuro, il mondo globalizzato, ignaro della natura e dell’ambiente, verso cui tutti vogliono correre e trasportare dietro di sé anche il mondo coreano, ancorato caparbiamente alla sua visione della vita, a quella filosofia corale, radicalmente alternativa al nostro modo d’intendere il vivere sociale e le libertà individuali.
In Corea del Nord la dimensione collettiva della vita è nettamente prevalente su quella individuale: le manifestazioni coreografiche, l’organizzazione del lavoro nelle cooperative, le grandi parate militari, i gruppi di gente che la domenica si recano nei parchi, si riuniscono sotto gli alberi e cantano e mangiano insieme, le colonie dei bambini che vanno al mare con l’organizzazione del Partito sono fenomeni che ci parlano, sì, di un mondo controllato e disciplinato, ma anche di vita comunitaria e di solidarietà. Siamo sicuri che la soluzione occidentale, con il suo individualismo esasperato e i suoi fenomeni di solitudine, con le tragiche conseguenze che tutti conosciamo, sia la migliore in assoluto?
La mitologia costruita attorno al Presidente eterno e alla dinastia ereditaria, il culto della personalità, fenomeni sovente presi di mira dal sarcasmo e dal disprezzo occidentali, costituiscono un laboratorio contemporaneo che potrebbe far luce sulla nascita dei miti e sull’origine di una dinastia ereditaria che, caso unico nell’universo comunista, ha caratteri simili a quelli delle antiche civiltà. Ci si potrebbe chiedere in che misura la storia coreana, con le sue tradizioni buddiste e confuciane, abbia influito su una particolare forma di socialismo che non ha eguali in altre parti del mondo.
Purtroppo, ho avuto modo di osservare, in più di un’occasione, come l’Occidentale in visita in Paesi molto diversi dal suo, ponga sempre se stesso al centro del mondo e della storia, dando giudizi affrettati sulle altre culture, con la certezza dogmatica di chi ha risolto tutti i misteri della vita. Non appena vede un elemento che ricorda la nostra società del passato, subito dipinge “gli altri” come arretrati, fermi agli anni Venti o Cinquanta o Sessanta, come se l’Occidente fosse il fulcro attorno al quale ruota la storia del mondo, il centro temporale a cui tutti i popoli si devono uniformare. E più il sistema osservato è lontano da quello abituale, più l’esperimento sociale è audace, più i giudizi si fanno astiosi, intrisi di disprezzo, fino a rasentare la xenofobia. I Nordcoreani sono stati dipinti come un popolo di automi o di schiavi; a volte vivono in città vuote, finte, non si sa dove; altre si muovono a branchi, sempre in silenzio, vittime di un sistema spietato e disumano. A nessuno è venuto il dubbio che, se per caso fosse vero, ciò significherebbe che la mente umana è così fragile e malleabile che ogni sistema può farne ciò che vuole. E allora l’esperimento coreano potrebbe farci venire qualche dubbio anche sul nostro sistema, sulla nostra tanto sbandierata libertà. Siamo proprio sicuri che il nostro sia il migliore dei mondi possibili? In realtà, a qualcuno, già duecento anni fa, qualche dubbio era venuto.
“Nessuna persona ridotta in schiavitù vive in condizioni peggiori di coloro che credono a torto di essere liberi”. Lo disse Johann Wolfgang von Goethe.
Fonti
La Corée, aperçu général, Editions en Langues Etrangères, Pyongyang, 1999;
Kim Kwang Il, Pak Hak Il e Han Jong Yon, Anecdotes relatives à Kim Il Sung, Editions en langues étrangères, Pyongyang, 2011;