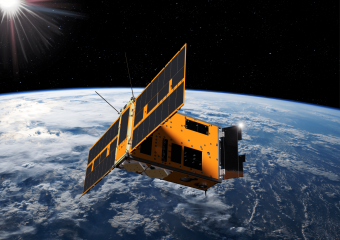Nella foto a destra: il “Ponte d’Attila” a Parma
Da Parma a Reggio
Nel 1988, quando Parma venne gemellata con Szeged, nessuno ricordò che il re Attila, sepolto nel letto del Tibisco nei pressi della città ungherese, era l’eponimo di un ponte sul torrente Parma.
Infatti il più meridionale dei ponti che a Parma attraversano il torrente omonimo, al di fuori delle antiche mura, almeno dal XIII secolo è chiamato Ponte Dattaro: “pons, qui est super flumen Parmae, qui dicitur Datari“, si legge negli statuti comunali del 1266. La tesi che collega il nome ad una ipotetica famiglia Dataro non è documentata, mentre la denominazione può essere spiegata solo se si considera che il ponte venne anche indicato come Pons Atilae, “Ponte di Attila”.
Il re unno però non fu mai a Parma; anzi, non risulta che sia mai sceso a sud del Po. Dopo avere espugnato Aquileia il 18 luglio 452 e dopo averla distrutta, egli si diresse verso il grande fiume e, seguendone la riva sinistra, avanzò fino a Pavia e fino a Milano, saccheggiando anche queste città, una dopo l’altra. Alla fine dell’estate le forze unne si erano spostate di 130 chilometri a sud-est di Milano, in direzione di Mantova. Fu lì, nei pressi del Mincio, che Attila ricevette la famosa ambasceria inviatagli dall’imperatore Valentiniano III e guidata da papa Leone Magno in persona, dopo di che fece ritorno nel bacino dei Carpazi.
La denominazione di Pons Atilae, sfuggita all’attenzione dei linguisti che hanno indagato sulla presenza del nome di Attila nella toponomastica (1), costituisce verosimilmente una delle tante tracce lasciate nella nomenclatura toponimica dalle incursioni degli Ungari, i quali, essendo correntemente identificati con gli Unni, rinverdirono mezzo millennio più tardi la fama leggendaria del “flagello di Dio”.
Finora si è ritenuto, sulla scorta di quanto scrive Ireneo Affò (2), che l’unico indizio del passaggio degli Ungari nel territorio di Parma fosse rappresentato dalla “traslazione delle reliquie di San Nicomede da Fontanabroccola a Parma, ben protetta dalle sue mura” (3) e che un altro probabile segno del loro passaggio fosse “la desolazione di una chiesa a Guastalla” (4), che apparteneva alla diocesi di Reggio.
Ciò dovette avvenire all’epoca dell’incursione iniziata nell’898, quando gli Ungari, che erano entrati in Emilia nei pressi di Piacenza e ne avevano devastati i sobborghi, nell’anno 900 infuriarono nel Reggiano danneggiando gravemente San Tommaso e probabilmente la cattedrale stessa.
Nel Catalogo dei vescovi di Reggio (5) si legge che in quella circostanza gli Ungari trucidarono, insieme con molti chierici, anche il vescovo Azzone (Azzo, qui interfectus est a paganis).
Benché la notizia dell’uccisione del vescovo di Reggio non sia del tutto certa e sia stata contestata già nel sec. XVIII (6), tuttavia i danni riportati dalla Chiesa reggiana furono così ingenti, che Berengario dovette intervenire elargendo beni di proprietà regia, “providens – come si legge testualmente in un diploma dell’anno 904 – eiusdem ecclesiae necessitates vel depredationes atque incendia quae a ferocissima gente Hungarorum passa est” (7).
Il monastero di San Tommaso poté così essere ricostruito: “coenobium Sancti Thomae (…) reaedificatum, olim ab infidelibus funditus destructum“, secondo quanto si legge in un documento (8).
Il vescovo di Reggio succeduto ad Azzone, subito dopo l’incursione che probabilmente era costata la vita al suo predecessore, nell’ottobre dell’anno 900 ottenne da Ludovico III il diritto di fortificare la sua chiesa con un giro di mura: “licentiam circundandi iam dictam ecclesiam per girum suae potestatis (…) excelsa munitione undique ad perpetuam ecclesiae suae defensionem” (9).
Undici anni dopo, imitando altri vescovi e signori feudali che si affrettavano a costruire fortificazioni atte a difendere le popolazioni dalle incursioni ungare, il vescovo di Reggio costruì un castello in una località chiamata Vicolongo (10). La ricostruzione delle chiese e dei conventi devastati dagli Ungari si protrasse fino al sec. XI; nell’anno 1000 venne fondato a Reggio un nuovo monastero, dedicato a San Pietro e a San Prospero.
Da Modena a Bologna
Proseguendo dunque la loro cavalcata lungo la via Emilia, gli Ungari arrivarono a Modena, probabilmente verso la fine di gennaio.
La leggenda di S. Geminiano, la sola fonte di questo episodio, racconta che all’arrivo dei barbari il vescovo, il suo clero e i fedeli si diedero alla fuga, abbandonando al proprio destino sia la chiesa in cui era sepolto San Geminiano sia gran parte del tesoro della chiesa. Entrati furibondi nella città deserta, gli Ungari sarebbero rimasti per qualche ora nella chiesa di San Geminiano e poi avrebbero lasciato la città senza torcere un capello a nessuno (sine alicuius laesione), grazie all’intercessione del Santo (obtentu gloriosissimi et saepe nominandi patris) (11).
Gina Fasoli, nel vecchio ma ancor fondamentale studio su Le incursioni ungare in Europa nel secolo X, ha sollevato una serie di irriverenti obiezioni alla versione agiografica dell’evento.
“Ci si domanda infatti – scrive la Fasoli – a che cosa servivano le mura innalzate dal vescovo Liduino, se i barbari entrarono così facilmente senza combattere (…) e ci si domanda anche a che cosa servivano quelle scolte modenesi che vigilavano dall’alto delle mura invocando contro gli Ungari la protezione di S. Geminiano (…) come mai i Modenesi fuggirono dalla loro città così ben fortificata e dove fuggirono, se scapparono così in fretta che non presero con sé nemmeno le sacre reliquie di S. Geminiano e tutto il tesoro della sua chiesa? (…) Sembra insomma storicamente molto più prudente – conclude la Fasoli – respingere la narrazione dell’Anonimo, anche se è stata finora tradizionalmente accettata, e ritenere che Modena, protetta come Parma e tante altre città dalla cerchia delle sue solide mura, vigilata dai cittadini, non ebbe a patire alcun danno dagli invasori” (12).
Sicuramente gli Ungari devastarono il contado modenese ed assalirono l’abbazia di Nonantola, uno dei più importanti monasteri dell’Italia settentrionale. A quanto si legge nel Catalogo dell’Abbazia di Nonantola, alcuni monaci, tra cui l’abate Leopardo, trovarono scampo nella fuga, ma la maggior parte di loro fu trucidata e l’edificio venne dato alle fiamme, insieme con la preziosa biblioteca (Venerunt usque ad Nonantulam et occiderunt monachos et incenderunt monasterium et codices multos concremaverunt (…) abbas Leopardus cum certis aliis monachis fugierunt et aliquanto latuerunt). In seguito tuttavia la comunità monastica si ricostituì e l’abbazia fu ricostruita: “Postea vero recongregati sunt et recondiderunt monasterium et ecclesiam” (13).
Mentre si può attribuire agli Ungari “la scomparsa di altri piccoli monasteri nell’agro persicetano che dipendevano dal monastero di Montecassino e di cui si perdono le tracce” (14), risultò invece vano il tentativo dei barbari di appiccare il fuoco alla chiesa di Santo Stefano, situata ad est di Bologna, fuori dalla cinta muraria; un insuccesso, questo, che fu attribuito all’intercessione di San Petronio.
Quanto alla via d’Ungheria, nome portato ancora nel 1294 dall’attuale via Schiavonia a Bologna, Giovan Battista Pellegrini, che si è occupato dei numerosi toponimi italiani relativi agli Ungari, dichiara di non sapere “quale fondamento abbia qui tale nome in rapporto con le incursioni” (15).
Non è escluso, invece, che risalga alle scorrerie di quel periodo la denominazione di strada Ungarista o via Ungaresca data alla strada che presso Forlì correva parallela alla via Emilia.
In ogni caso, da Bologna le schiere ungare tornarono verso il Po e lo passarono “probabilmente ad Ostiglia, nodo stradale frequentatissimo in tutti i tempi” (16).
In giugno, un contingente di truppe ungare attraversò la laguna di Venezia, con cavalli e barchette fatte di pelli, e devastò Chioggia ed altri centri minori; ma il 29 giugno si trovò davanti la flotta veneziana e fu costretto a ritirarsi.
Il Ritmo Modenese
Quel vero e proprio gioiello di poesia latina medioevale che va sotto il nome di Ritmo Modenese fu trovato in un codice del secolo XI della Cattedrale di Modena da Lodovico Antonio Muratori, il quale lo pubblicò inizialmente nelle Antiquitates Italicae Medii Aevi (17) facendolo risalire all’anno 924.
Il carme fu successivamente pubblicato nei Monumenta Germaniae Historica tra i componimenti poetici dell’età carolina (18) da Ludwig Traube, il quale invece lo anticipò al biennio 899-900, cioè all’epoca in cui Modena poté resistere alle incursioni ungare grazie alle sue forti mura ricostruite sul finire del sec. IX dal vescovo Liduino, grazie alla vigilanza delle sue scolte e soprattutto, secondo quanto attestato dal carme, grazie all’intercessione del santo patrono della città.
Il carme esordisce raccomandando agli uomini di guardia sulle mura di vigilare contro il pericolo di un improvviso attacco nemico:
O tu, qui servas armis ista moenia,
noli dormire, moneo, sed vigila !
Come exempla di vigilanza, vengono citati due celebri episodi: il primo è quello dell’espugnazione di Troia, addebitata al fatto che le sentinelle si erano abbandonate al sonno e non si erano accorte che dal ventre del cavallo di legno uscivano i guerrieri greci, mentre il secondo episodio è quello delle oche del Campidoglio che misero in fuga i Galli invasori.
Dopo avere invocato Cristo affinché vigili su Modena e ne difenda la cinta muraria con la sua lancia e dopo aver invocato la Santa Vergine e l’Apostolo Giovanni, il carme fa appello ai giovani della città (fortis iuventus, virtus audax bellica) perché si avvicendino nei turni di guardia sulle mura.
A questo punto ci si rivolge a San Geminiano, chiedendogli di pregare il Re dei Cieli affinché salvi Modena dal flagello presente, che pure non sarebbe immeritato:
Confessor Christi, pie Dei famule,
Geminiane, exorando supplica,
ut hoc flagellum, quod meremur miseri,
celorum regis evadamus gratia.
D’altronde già “ai tempi di Attila” (Attile temporibus) il santo patrono aveva salvato la città da un pericolo analogo. Infatti, secondo una pia leggenda, per salvare Modena dagli Unni di Attila San Geminiano (che era morto mezzo secolo prima, nel 397) avvolse la città entro una fitta coltre nebbiosa, inducendo i barbari invasori a passare oltre. Si tratta di un miracolo analogo a quello che viene attribuito a San Prospero, vescovo di Reggio Emilia nel V secolo, il quale avrebbe salvato la città da una non meglio identificata incursione di Unni producendo il miracolo della nebbia.
Nel Ritmo Modenese, dunque, la rievocazione della figura di Attila introduce la menzione dei barbari nepoti, che costituiscono la minaccia presente.
Contro le frecce degli Ungari, temibili arcieri, i Modenesi invocano la difesa del santo patrono, anche se per i loro peccati riconoscono di non esserne degni:
Nunc te rogamus, licet servi pessimi,
ab Hungarorum nos defendas iaculis.
Ed è sempre San Geminiano ad essere ringraziato con questa strofe di ottonari trocaici rimati:
Tandem urit Hungarorum
gens nefanda et cunctorum
loca perdit: sed suorum
Sanctus servat moenia.
“Infine la gente nefanda degli Ungari incendia e distrugge gl’insediamenti di tutti; ma il Santo salva le mura dei suoi”, cioè dei suoi Modenesi.
Un altro testo liturgico (19), stilisticamente più elaborato, dice:
Stella fulget in nebula,
dum fugit Ungarorum
gens furens, visa cellula,
Flos, in qua confessorum
Geminianus parvula
lux humatus, quam horum
sic mox illaesa singula
liquit gens perfidorum.
“Mentre la furente gente degli Ungari fugge, una stella risplende nella nebbia. La celletta in cui è sepolto il Fiore dei Martiri, Geminiano, è una piccola luce, l’unica che l’orda di questi infedeli lascia intatta”.
La vittoria ungara sul fiume Brenta
Cerchiamo adesso di delineare sinteticamente il contesto storico degli eventi che ispirarono l’autore (o gli autori) del Ritmo Modenese.
Il 21 febbraio 896 Arnolfo di Carinzia, re dei Franchi orientali, riceveva in San Pietro la corona imperiale. Già nell’892 il sovrano aveva stretto con gli Ungari un patto per averli alleati contro le popolazioni della Moravia; in pochi anni, gli Ungari annientarono il principato moravo, sul territorio del quale fu creata una zona di confine corrispondente grosso modo all’Austria odierna. Fu così che gli Ungari si resero conto dell’opulenza dei territori occidentali e delle opportunità di bottino che questi presentavano. D’altronde già a partire dall’862, quando erano ancora stanziati oltre il Dnepr, essi avevano effettuato sporadiche incursioni contro i territori orientali del Sacro Romano Impero.
Perciò nell’899, tre anni dopo l'”occupazione della patria” nel bacino danubiano, gli Ungari accolsero ben volentieri la nuova richiesta d’aiuto di Arnolfo, che dopo essere stato incoronato a Roma doveva sistemare i conti col suo rivale, Berengario I.
In primavera (in agosto secondo altre fonti) arrivò dunque nella Pianura Padana un esercito di cinquemila cavalieri ungari che cominciò a devastare e saccheggiare la regione.
Liutprando (915-972) così registra l’evento nell’Antapodosis (20) da lui scritta fra il 959 e il 962, anno in cui diventò vescovo di Cremona.
“Il Sole non aveva ancora lasciato il segno dei Pesci per occupare quello dell’Ariete, quando, dopo aver radunato un immenso e innumerevole esercito (immenso atque innumerabili collecto exercitu) [gli Ungari, ndr] si dirigono in Italia; oltrepassano Aquileia e Verona, città molto ben fortificate (munitissimas civitates), e giungono a Ticinum – che ora con altro termine più insigne viene chiamata Pavia (Papia) – senza che nessuno opponga resistenza (nullis resistentibus). Re Berengario non poté stupirsi abbastanza per un evento così straordinario e senza precedenti (tam praeclarum novumque facinus); prima d’allora, infatti, non aveva nemmeno udito il nome di questo popolo” (21).
Trovandosi nella necessità di difendere i suoi sudditi dall’invasione barbarica, Berengario, che si trovava nell’Italia centrale, raccolse un esercito di circa 15.000 uomini, 25.000 secondo qualcuno, in ogni caso un numero almeno triplo di quello dei nemici (exercitus triplo Hungariorum validior, dice Liutprando), e marciò verso il Po.
Gli Ungari disponevano di un’intelligenza tattica e di una tecnica militare che consentì loro di infliggere numerose sconfitte ad avversari più numerosi. Ciascuno di loro montava un cavallo, erano addestrati nell’uso dell’arco, della lancia e della spada, cosicché potevano adoperare le armi a seconda delle necessità. La loro cavalleria era in grado di suddividersi in unità militari più piccole, veri e propri “corpi tattici” che ubbidivano disciplinatamente ciascuno al proprio comandante, puntavano tutto sulla rapidità delle operazioni e sull’effetto sorpresa. Prima dell’attacco tempestavano il nemico con una fitta grandine di frecce, provocando lo scompiglio della cavalleria avversaria e investendola subito dopo con i loro cavalli. Maestri nelle astuzie belliche, simulavano la fuga per attirare il nemico in un agguato già predisposto. Diventavano vulnerabili, invece, quando dovevano trascinare pesanti carri carichi di bottino, perché ciò li privava della loro caratteristica mobilità. Le loro incursioni erano sempre precedute dalle attività degli esploratori, i quali si procuravano informazioni sulla natura e sulla situazione politica del paese da attaccare.
Stavolta però gli Ungari si trovano davanti a un esercito che è almeno il triplo del loro. Anzi, siccome Berengario sta per passare il Po, essi, che sono già arrivati a Pavia, temono di vedersi tagliare la via del ritorno; perciò decidono di rinunciare all’impresa e si ritirano a est dell’Adda, ma in tanta fretta e furia che molti vi muoiono annegati.
Ecco come Liutprando descrive la situazione.
“Appena gli Ungari videro una moltitudine così grande, costernati nell’animo, non riuscivano a deliberare circa il da farsi. Avevano un gran timore di combattere, ma non potevano assolutamente fuggire (preliari penitus formidabant, fugere omnino nequibant). Però, ondeggiando nel dubbio, ritengono che sia meglio fuggire anziché combattere; e, sotto l’incalzare dei Cristiani, attraversano a nuoto il fiume Adda, cosicché per la fretta eccessiva moltissimi morivano annegati (persequentibusque Christianis Adduam fluvium natando, ita ut nimia festinatione plurimi necti submergerentur, pertranseunt)” (22).
Vista la mala parata, “gli Ungari prendono la saggia decisione di inviare dei messaggeri a chieder la pace ai Cristiani, al fine di poter ritornare incolumi, restituendo tutta la preda e il bottino (praeda omni cum lucro reddita). I Cristiani respinsero totalmente questa richiesta e, ahimé (pro dolor), – così si lamenta Liutprando – li insultavano, e cercavano catene con cui legare gli Ungari, piuttosto che armi con cui ucciderli. I pagani, non potendo addolcire gli animi dei Cristiani con questa proposta, ritenendo che fosse migliore la vecchia decisione, cercano di liberarsi iniziando la fuga e così fuggendo giungono nelle vastissime campagne veronesi (in Veronenses latissimos campos perveniunt)”(23).
Qui, fra l’avanguardia degl’inseguitori e la retroguardia degl’inseguiti, avviene una prima scaramuccia, che si risolve a vantaggio dei barbari (“in quo victoriam habuere pagani“) (24).Poi, siccome si avvicina l’esercito italico, gli Ungari proseguono la ritirata. Ma, siccome i cavalli ormai sono sfiancati, sono costretti a fermarsi sulla riva orientale del Brenta, sempre incalzati dagli Italici, che si fermano sull’altra sponda.
Ancora una volta gli Ungari si dichiarano disposti a consegnare il bottino, i prigionieri, le armi e i cavalli, tranne quelli necessari per proseguire nella ritirata. Anzi, promettono che, se verranno risparmiati e potranno andarsene sani e salvi, non metteranno mai più piede in Italia, lasciando in ostaggio i loro figli a garanzia dell’impegno assunto. La proposta però viene respinta. “Ma, ahimé, – si lamenta ancora il cronista – i Cristiani, accecati dalla superbia (superbiae tumore decepti), continuano a minacciare i pagani come se li avessero già vinti” (25).
Il 24 settembre 899 gli Ungari decidono di passare all’attacco, dividendosi in tre gruppi che attraversano il Brenta e aggrediscono su tre lati gl’Italici, che sono scesi da cavallo e si stanno ristorando di cibo e di riposo. L’azione è fulminea: “gli Ungari – scrive Liutprando – li trafissero con così grande rapidità, che ad alcuni infilzarono il cibo in gola (quos tanta Hungarii celeritate confoderant, ut in gula cibum transfigerent), ad altri portarono via i cavalli, impedendo loro la fuga e tanto più facilmente li uccidevano, in quanto avevano visto che erano senza cavalli”.
“Ad accrescere infine la rovina dei Cristiani – prosegue il cronista – vi era tra loro una discordia non piccola. Alcuni, addirittura, non solo non combattevano contro gli Ungari, ma desideravano che i loro vicini cadessero; e questi perversi lo facevano in maniera perversa (perversi ipsi perverse fecerant), al fine di regnare da soli, più liberamente, purché cadessero i vicini. Mentre trascurano di soccorrere alle necessità dei vicini e ne desiderano la morte, corrono essi stessi incontro alla propria. Pertanto i Cristiani fuggono e i pagani infieriscono (fugiunt itaque Christiani, saeviuntque pagani); e quelli che prima non erano riusciti a supplicare coi doni, non sapevano poi risparmiare i supplici” (26).
Le devastazioni in Emilia
In seguito alla sconfitta, Berengario si rinchiuse in Pavia coi resti del suo esercito, ormai praticamente dissolto. La durissima disfatta lo indebolì di fronte all’aristocrazia, che ben presto gli oppose Ludovico di Provenza, e di fronte alle popolazioni, che rimasero esposte alle scorrerie degli Ungari.
Questi infatti ripresero a saccheggiare la Valle Padana, finché alla metà di dicembre una parte di loro da Vercelli si avviava verso il Gran San Bernardo, mentre un’altra parte passava il Po, probabilmente presso Pavia, nel luogo che da loro prese il nome di Popula Pagana, e procedendo sulla riva destra arrivò sotto le mura di Piacenza. Imboccata la Via Emilia, si diressero verso Parma e iniziarono quella serie di devastazioni di cui si è detto più sopra.
Successivamente, fra il 903 e il 904, l’Italia fu obiettivo di un’altra incursione ungara, della quale le fonti non consentono di determinare l’area in maniera precisa.
Probabilmente la nuova scorreria si limitò alle zone a nord del Po; sicuramente coinvolse Aquileia e Piacenza e indusse i bergamaschi a rafforzare le fortificazioni cittadine.
Berengario, che nel frattempo aveva prevalso sul rivale Ludovico III ed aveva ripreso Pavia, stavolta preferì venire a patti con gli Ungari e instaurare con loro relazioni di amicizia, “datis obsidibus ac donis” (27), ossia elargendo donativi e consegnando anche degli ostaggi come pegno di alleanza.
Gli studiosi ungheresi sostengono che nel 904 venne conclusa una vera e propria tregua, la quale fu osservata fino al 919, poiché per quindici anni gli Ungari rivolsero le loro attenzioni a Baviera, Turingia e Sassonia.
Ciò consentì alle popolazioni italiche di predisporre opportune fortificazioni in previsione della fine della tregua. Mentre il vescovo di Reggio succeduto ad Azzone, come già si è detto, erige un castello a Vicolongo, “il Vescovo di Modena, che ha costruito insieme con gli abitanti il castello di Cittanuova [sic] concedendo degli appezzamenti presso le mura, fa ai concessionari obbligo di costruirvi una casa e di abitarvi, di provvedere alla difesa e alla manutenzione del castello, esigendo un censo che varia dall’uno all’altro e senza impegnarsi a non pretendere altri tributi” (28). Tra il 916 e il 922 anche il borgo di Carpi viene rifondato come roccaforte (castrum Carpi).
Nel 919, dopo aver ottenuto la corona imperiale, Berengario dovette far fronte ad alcuni vassalli che gli opponevano Rodolfo di Borgogna; per liberarsi degli avversari, pensò bene di assoldare due contingenti di cavalieri ungari, comandati da due capi di cui Liutprando ci ha trasmesso i nomi: Dursac e Bugat.
Tuttavia, per quanto fossero – sempre secondo Liutprando – “grandi amici” di Berengario, i contingenti ungari si comportarono come in un territorio di conquista. Una parte di questi gruppi si unì ad altre schiere sopraggiunte dall’Ungheria e nel 922 scese per la costa adriatica fino alla Puglia sotto il comando di un Salardo (Szovárd) che probabilmente è da identificarsi con lo Zoard delle tarde cronache ungheresi.
Dopo la battaglia di Fiorenzuola, nella quale Rodolfo di Borgogna si scontrò con Berengario e coi suoi alleati ungari, questi ultimi, comandati da Salardo, il 12 marzo 924 strinsero d’assedio Pavia e la incendiarono con le loro frecce infuocate.
Un mese più tardi, il 7 aprile 924, Berengario cadde vittima di una congiura ordita dai fautori di Rodolfo. I capi ungari, non più legati dal patto col sovrano, nel 927 misero a ferro e fuoco la Toscana e il Lazio, anche qui inserendosi nelle lotte intestine dei signori italiani.
“Particolarmente notevole per la sua estensione territoriale – scrive uno storico delle invasioni barbariche – fu però soprattutto la grande spedizione del 937, che vide gli ungari entrare nella penisola da nordovest, attraverso il Moncenisio e il Monginevro, e spingersi progressivamente sempre più a sud, lungo il tradizionale percorso che conduceva dalle Alpi occidentali a Roma, fino a giungere in Campania, per poi risalire da qui lentamente, uscendo infine, con ogni probabilità, dalla frontiera nordorientale. Proprio nel viaggio di ritorno gli ungari subirono una dura sconfitta per mano degli abitanti della Marsica, i quali sorpresero dentro un’impervia gola montana i nemici, rallentati nella marcia dal cospicuo bottino raccolto nella lunga scorribanda, e inflissero loro una severa punizione” (29).
Una successiva apparizione di Ungari sotto le mura di Roma ebbe luogo nel 942, ma gl’invasori furono affrontati e respinti; e nei pressi di Rieti dovettero subire un’altra sconfitta.
Le ultime scorrerie nella penisola ebbero luogo tra il 952 e il 954, quando vennero attaccate Torino e Susa.
Le incursioni ungare, che tra l’898 e il 955 avevano superato la trentina in tutta l’Europa occidentale, si erano ridotte nel tempo “sia per la maggior capacità di resistenza degli aggrediti sia, forse, per una diminuzione della spinta propulsiva dello stesso mondo ungarico” (30).
Esse cessarono definitivamente dopo la sonora sconfitta che nel 955 Ottone I inflisse agli Ungari a Lechfeld presso Augusta. Da allora gli Ungari si stabilizzarono nel bacino carpato-danubiano, si convertirono al cristianesimo romano e costruirono un regno che costituì un’antemurale contro altri popoli di cavalieri nomadi, come i Peceneghi o i Cumani.
Sei secoli dopo la battaglia di Lechfeld, un documento custodito presso l’Archivio di Stato di Parma e datato 19 febbraio 1559 attesta un giuramento di fedeltà agli Statuti parmensi sottoscritto dai maggiorenti delle Valli dei Cavalieri, tra i quali figurano tre esponenti di una famiglia d’origine ungherese: Magiarus, Hillarius e Bartholomeus de Magiaris.
I de Magiaris, che si estinsero nel XVII secolo, erano probabilmente “discendenti di qualche disertore magiaro, già appartenente allo sconfitto corpo di spedizione ungaro mandato dall’Albornoz ad assalire Parma, durante il periodo della signoria viscontea” (31).
Cessato il periodo delle incursioni, era dunque iniziata nella storia del popolo magiaro una nuova era, nel corso della quale esso era diventato membro della famiglia europea, a pieno titolo e con pari dignità.
1. G. Serra, Da Altino alle Antille. Appunti sulla fortuna e sul mito del nome ‘Altilia’, ‘Attilia’, ‘Antilia’, in Lineamenti di una storia linguistica dell’Italia medioevale, I, Liguori, Napoli 1954, pp. 1-66.
2. I. Affò, Storia della città di Parma, Parma 1792, p. 203.
3. G. Fasoli, Le incursioni ungare in Europa nel secolo X, Sansoni, Firenze 1945, p. 105.
4. G. Fasoli, ibidem. Cfr. I Affò, Istoria di Guastalla, Guastalla 1785, p. 57.
5. Rerum Italicarum Scriptores, VIII, 1170.
6. G.. Tiraboschi, Memorie storiche modenesi, Modena 1798, I, p. 48.
7. I Diplomi di Berengario I, a cura di L. Schiaparelli, F.S.I., Roma 1903, XLII, 904, gennaio 4.
8. G. Bisoni, Gli Ungheri in Italia, in La scuola cattolica e il pensiero scientifico, S. III, 18, 1899, pp. 314-330, 486-502, vol. 19, 1900, pp. 269-295.
9. Dipl. Ludovico III, IV, 900, Ott. 31.
10. Dipl. Bereng. I, LXXV, a. 911.
11. Vita II di S. Geminiano, in Mon. Storia Patria delle province modenesi, XIV, 1, a cura di P. Bortolotti, p. 103.
12. G. Fasoli, op. cit., pp. 107-109.
13. Catal. Abb. Nonant., p. 572; cit. da G. Fasoli, op. cit., p. 109.
14. G. Fasoli, op. cit., pp. 109-110.
15. G. B. Pellegrini, Tracce degli Ungari nella toponomastica italiana ed occidentale, in: C.I.S.A.M. Atti delle settimane di studio. XXXV Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari (23-29 aprile 1987), Spoleto 1989, p. 323).
16. G. Fasoli, op. cit., 96.
17. Antiquitates Italicae Medii Aevi, vol. III, col. 703.
18. Poëtae aevi Carolini, vol. III, pp. 703-706.
19. G. Cappelletti, Le chiese d’Italia dalle loro origini fino ai giorni nostri, Venezia 1844, XI, p. 213.
20. Liutprandi Ticinensis Ecclesiae Levitae Rerum ab Europae Imperatoribus ac Regibus gestarum, in A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, tomo II, pp. 425-476.
21. Liutprando, Antapodosis, II, 9.
22. Antapodosis, II, 10.
23. Antapodosis, II, 11.
24. Antapodosis, II, 12.
25. Antapodosis, II, 13.
26. Antapodosis, II, 15.
27. Giovanni Diacono, Chronicon venetum, F.S.I., G. Monticolo, Roma 1890, p. 22.
28. G. Fasoli, op. cit., p. 217.
29. C. Azzara, Le invasioni barbariche, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 135-136.
30. C. Azzara, op. cit., p. 137.
31. G. Capacchi, Storia, leggenda e araldica “minore” nelle Valli dei Cavalieri, “Aurea Parma”, 1963, p. 76.
![Share on Facebook facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()
![Share on Facebook facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()